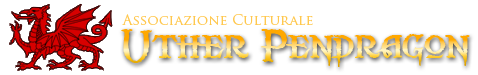La città di Trieste
 Circa le origini della città di Trieste, la storia si intreccia alla leggenda. Una antichissima leggenda narra che il fondatore della città fosse Tergeste, un amico di Giasone e degli Argonauti e che qui volle fermarsi.
Circa le origini della città di Trieste, la storia si intreccia alla leggenda. Una antichissima leggenda narra che il fondatore della città fosse Tergeste, un amico di Giasone e degli Argonauti e che qui volle fermarsi.
Nella prima metà del 3000 a.C. tribù protovenete si insediarono sull’odierno Colle di San Giusto, ove si sviluppò il villaggio. In merito all’etimologia del nome di Trieste, ci sono due ipotesi.
L’antica Tergeste, divenne colonia romana intorno al 178 a.C. collocandosi sul Colle di San Giusto ed era costituita da una piccola fortificazione dotata di mura, e da qui si espanse l’antico e fiorente villaggio, grazie anche all’importanza degli scambi commerciali che avvenivano via mare. Con la caduta dell’Impero d’Occidente, inizia un periodo buio: con le invasioni barbariche, la città cadde sotto il dominio dei Goti, poi cacciati dall’imperatore bizantino Giustiniano, finché nel 568 Trieste viene distrutta dai Longobardi.
Nel 1202 il doge Enrico Dandolo assoggetta la città al dominio della Serenissima.
Nel Medioevo alla fine del XIII secolo Trieste, era un comune libero ed allora vennero anche coniate le prime monete. Di quel tempo è originaria anche l’alabarda che è il simbolo di Trieste.
Nel 1382 arriva la protezione del duca Leopoldo d’Austria destinata a durare per circa cinque secoli.
Tra il 1700 e il 1800, la città passa per tre occupazioni napoleoniche.
Nel 1920, dopo che i bersaglieri nel 1918 sbarcarono con l’”Audace” al molo San Carlo (oggi molo Audace), Trieste fu ufficialmente incorporata al Regno d’Italia..
Dopo il tormentato e tragico periodo passato nell’ultima guerra, Trieste tornò ad ammessa all’Italia solo il 26 ottobre 1954.
Paganesimo a Trieste
 La grotta del Dio Mitra, nell’area delle fonti del Timavo, è una preziosissima reliquia del passato, una finestra sulla storia più antica.
La grotta del Dio Mitra, nell’area delle fonti del Timavo, è una preziosissima reliquia del passato, una finestra sulla storia più antica.
Si tratta di una cavità naturale in cui si praticava il culto misterico del dio Mitra, diffuso nel mondo romano dalla fine del I secolo sino al trionfo del cristianesimo. Al centro della grotta si trovano due banconi paralleli e tra di essi un blocco di calcare, squadrato, su cui veniva spezzato il pane durante le cerimonie religiose.
Sulla parete di fondo trova spazio il calco di una lapide sostenuto da delle colonnine: raffigura il dio Mitra mentre uccide il toro primigenio. Così recita la dedica: “All’invitto dio Mitra Aulo Tullio Paumniano offre per la sua salute e per quella dei suoi fratelli”. Nella grotta, inoltre, sono state trovate moltissime offerte: circa 400 monete, la più antica delle quali fu coniata da Antonino Pio, 160 lucerne e un gran numero di vasetti, tutti databili tra il I e il V secolo d.C.
Il tempio Mitreo di Duino è l’unico, in tutto il mondo, ad essere situato in una grotta ed è uno dei più antichi mai scoperti.
La grotta del Dio Mitra è piuttosto nascosta ma di facile accesso. Dista circa due chilometri dalle fonti del Timavo, in direzione di Duino. Si percorre la statale 14, sino al bivio che porta al centro di Duino.
Celti in Regione
 Come quasi tutte le regioni del nord e del centro Italia, anche il Friuli-Venezia Giulia ha radici celtiche. Ed è soprattutto nel periodo pre-romano che è stata attraversata da Celti, e Istro-Veneti.
Come quasi tutte le regioni del nord e del centro Italia, anche il Friuli-Venezia Giulia ha radici celtiche. Ed è soprattutto nel periodo pre-romano che è stata attraversata da Celti, e Istro-Veneti.
Intorno al 400 a. C. le tribú dei Carno-Celti -chiamati Galli dai Romani e poi passati alla storia con l’appellativo di Carni-, entrarono ufficialmente in Friuli nella zona oggi chiamata Carni, stabilendosi .
In molte altre zone del Friuli soggette a scavi archeologici, sono affiorati centinaia di reperti tra cui fibule, gioielli, ornamenti vari e spade, e da tutte queste testimonianze possiamo prender atto che qualcuno di noi può trovare le proprie radici in questo fiero popolo antico.
Ma veniamo a Trieste, la già nota Tergeste romana. E’ stato ipotizzato che il suo etimo derivi ancor prima dalla parola celtica “Terges”, che significa “mercato”, e ciò già potrebbe far presumere un’origine celtica prima ancora che romana. In effetti, visto i numerosi commerci che i Celti avevano con tutti paesi a noi confinanti, è un’ipotesi da non scartare.
….. ma ecco una curiosità:
uno dei vari misteri sui Celti a Trieste, è quello dell’anfiteatro (naturale?) meglio conosciuto come “Dolina Celtica”, situata a Basovizza dove purtroppo, nemmeno la prova con il carbonio 14 è riuscita ad attribuirne la datazione certa né risalire alle sue origini. Ma…, su di una pietra del sito (ancora presente ma non facilmente individuabile), è stata trovata un’incisione raffigurante un guerriero celtico (!), mentre un’altra simile è stata usata per finire la costruzione del campanile di San Giusto.
Il mistero continua.
La vera storia del Kilt
 Il kilt, o gonnellino scozzese, così come lo conosciamo oggi, si è evoluto verso la metà del ‘700 dall’indumento, allora più diffuso e più funzionale, del panno con cintura (in gaelico feileadh breacan o feileadh mor, conosciuto anche come ‘Great Kilt’).
Il kilt, o gonnellino scozzese, così come lo conosciamo oggi, si è evoluto verso la metà del ‘700 dall’indumento, allora più diffuso e più funzionale, del panno con cintura (in gaelico feileadh breacan o feileadh mor, conosciuto anche come ‘Great Kilt’).
Il kilt originario
Il feileadh mor era un semplice panno della lunghezza di circa cinque metri che veniva raccolto in vita e fermato con una cintura e che serviva a coprire anche la parte superiore del corpo. Dalla vita in giù il feileadh mor aveva l’aspetto del kilt attuale, mentre il tessuto rimanente veniva portato sulla spalla, dove il drappeggio veniva fissato con un fermaglio. La parte superiore dell’indumento poteva essere combinata in modi diversi, a seconda del tempo che faceva, della temperatura e della libertà di movimento che si voleva ottenere.
L’evoluzione del kilt
Il feileadh mor fu semplificato con l’eliminazione della parte superiore, lasciando solo la cintura e il gonnellino. La nuova creazione prese il nome di feileadh beg, ‘il kilt piccolo’. Si ritiene che la semplificazione sia avvenuta per ordine del capo inglese di una ferriera di Invergarry che riteneva che i suoi dipendenti avessero bisogno di una maggiore libertà di movimento per svolgere il loro lavoro.
Bandito, il kilt resiste
Dopo la sconfitta subita dai giacobiti a Culloden nel 1746, il kilt e altri elementi dell’abbigliamento delle Highlands vennero messi al bando, e il fatto che il kilt non sia scomparso in quegli anni è dovuto in gran parte all’essere stato adottato dai reggimenti delle Highlands quando combattevano nell’esercito britannico. I reggimenti delle Highlands indossano tuttora regolarmente il kilt (anche se non più in battaglia), ma questo indumento non fa più parte dell’abbigliamento quotidiano degli scozzesi. Il visitatore ha più probabilità di vederlo indossato nelle cerimonie ufficiali, come i matrimoni e i raduni dei giochi tradizionali delle Highlands.
Il kilt attuale
Per il kilt attuale vengono utilizzati fino a otto metri di stoffa, fittamente pieghettata sul dietro e sui fianchi, e la pieghettatura è fermata da cuciture solamente in vita. Alcuni stilisti hanno anche cercato di aggiornare il kilt, e di attirare così un maggior numero di persone, facendo uso di tessuti diversi dal tartan e di altri materiali, come per esempio la pelle.